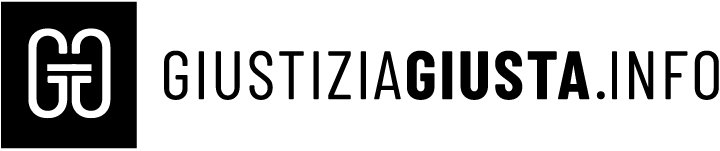Cos’è e come funziona il mutuo cointestato- www.giustiziagiusta.info
Nel panorama delle soluzioni finanziarie per l’acquisto di un immobile, il mutuo cointestato rappresenta un’opzione molto diffusa.
Ma quali sono i meccanismi che regolano questo tipo di finanziamento, e quali vantaggi e svantaggi comporta? Inoltre, come si gestiscono le situazioni di separazione o di difficoltà di uno dei cointestatari?
Questo approfondimento intende fornire una panoramica aggiornata e completa su mutuo cointestato, evidenziandone i principali aspetti giuridici e fiscali.
Il mutuo cointestato è un finanziamento erogato da un istituto di credito a due o più soggetti che, con la sottoscrizione del contratto, diventano coobbligati solidalmente al rimborso. In sostanza, ogni cointestatario risponde dell’intera somma residua dovuta, comprensiva di capitale, interessi e spese accessorie, e non soltanto della propria quota. Questo principio, noto come responsabilità solidale, implica che la banca può rivolgersi a uno o più mutuatari per il recupero dell’intero debito, indipendentemente dagli accordi interni tra le parti.
I cointestatari possono essere persone maggiorenni con capacità legale di contrarre, e non necessariamente comproprietari dell’immobile. È infatti comune che il mutuo venga cointestato a coniugi o conviventi di fatto per finanziare la casa familiare, ma anche a parenti, amici o soci, sebbene la banca possa richiedere la cointestazione a tutti i comproprietari dell’immobile ipotecato.
È importante distinguere il ruolo del cointestatario da quello del garante: quest’ultimo interviene solo in caso di inadempienza del mutuatario principale, mentre il cointestatario è obbligato in via diretta e solidale.
Vantaggi e opportunità del mutuo cointestato
Il principale beneficio del mutuo cointestato risiede nella possibilità di ottenere un finanziamento di importo più elevato rispetto a quello che potrebbe essere concesso a un singolo mutuatario. Le banche valutano la capacità di rimborso considerando i redditi complessivi dei cointestatari; pertanto, sommando i redditi di due o più persone, aumenta la soglia di accesso al mutuo.
Ad esempio, se un coniuge ha un reddito mensile di 1.800 euro e l’altro di 1.200 euro, la banca potrà concedere una rata complessiva più alta, che sarà suddivisa tra i mutuatari. Inoltre, in alcuni casi, la presenza di più intestatari può tradursi in condizioni economiche più favorevoli, come tassi di interesse più bassi.
Un altro aspetto positivo è la possibilità di suddividere l’impegno finanziario, rendendo meno gravoso il pagamento delle rate. Infine, non è obbligatorio aprire un conto cointestato per la gestione del mutuo: l’addebito può avvenire sul conto di uno solo dei cointestatari.

Tra gli aspetti da considerare con attenzione figurano le implicazioni legate a eventuali cambiamenti del rapporto tra i cointestatari, come la separazione o il divorzio. La legge prevede che gli obblighi derivanti dal mutuo permangano anche dopo la fine della convivenza o del matrimonio, salvo che non venga formalizzata una modifica del contratto con la banca o che uno dei cointestatari subentri nell’intero debito tramite una procedura di accollo.
In caso di inadempienza di uno dei mutuatari, la banca può richiedere l’intero pagamento all’altro o agli altri cointestatari, che potranno poi rivalersi internamente secondo gli accordi presi. Se il mancato pagamento persiste, l’istituto di credito può procedere al pignoramento e alla vendita all’asta dell’immobile ipotecato, il cui vincolo grava sull’intero bene indipendentemente dalle quote di proprietà dei singoli.
Anche la morte di uno dei cointestatari comporta la continuità dell’obbligo per gli altri, mentre gli eredi del defunto potrebbero dover subentrare nel debito o procedere alla vendita dell’immobile per estinguere il mutuo residuo, a seconda delle clausole contrattuali e delle disposizioni testamentarie.
Per evitare conflitti e complicazioni, è consigliabile che le coppie definiscano accordi chiari in sede di separazione o divorzio, stabilendo chi assumerà la responsabilità delle rate residue, eventualmente con l’intervento del giudice in caso di contenzioso.